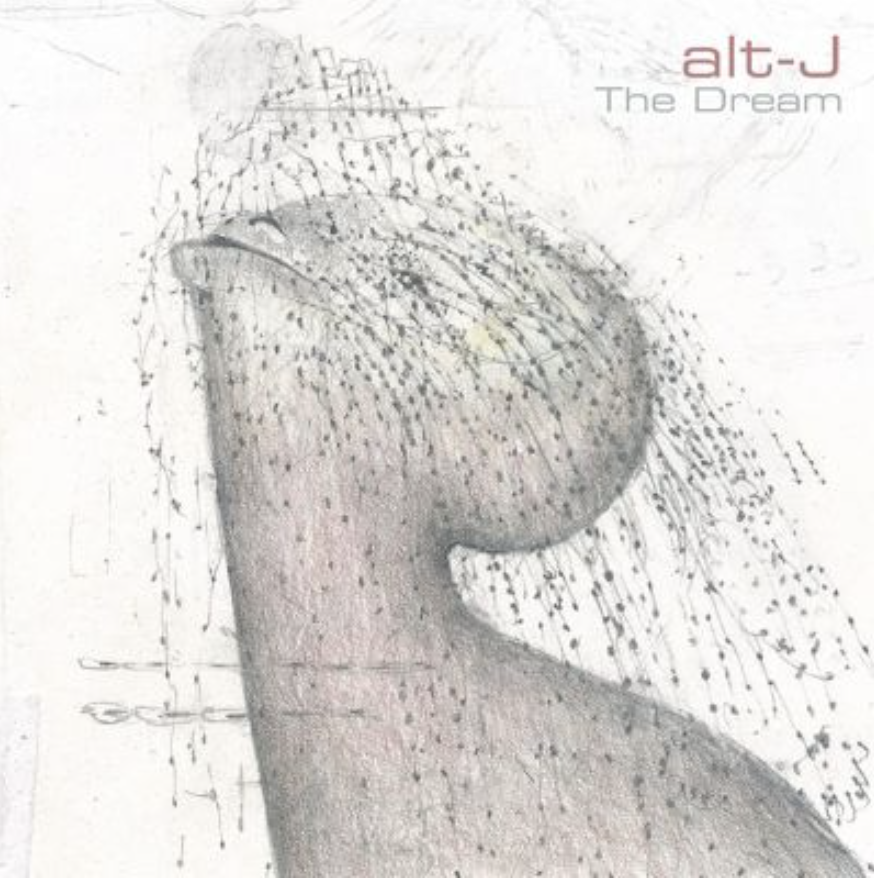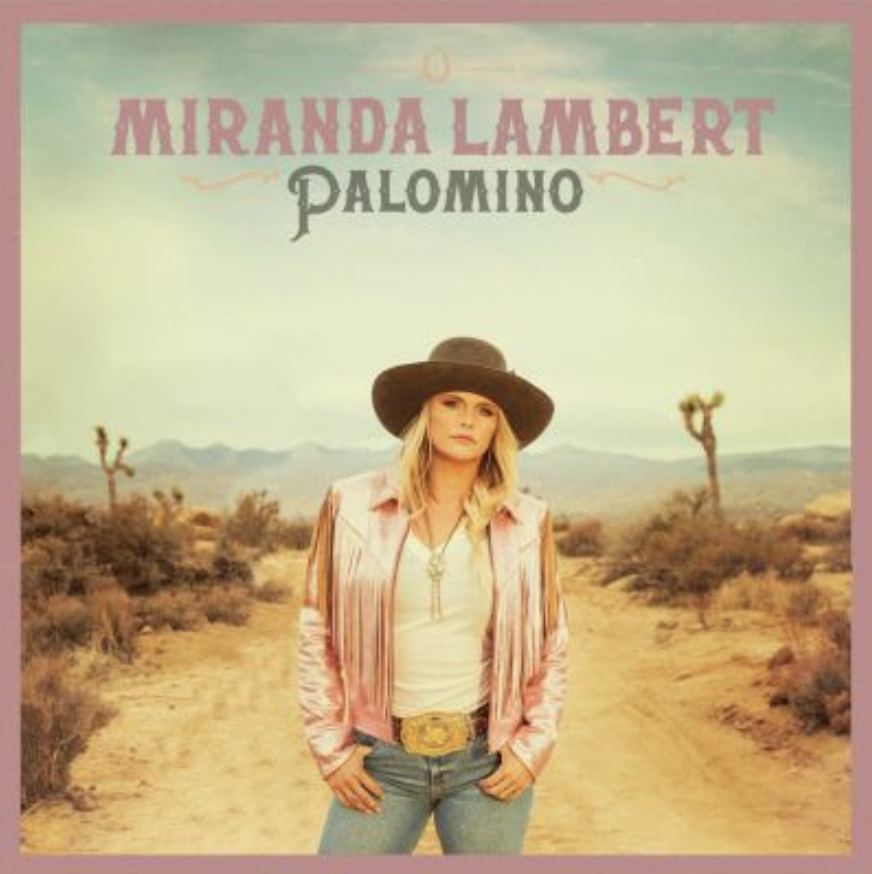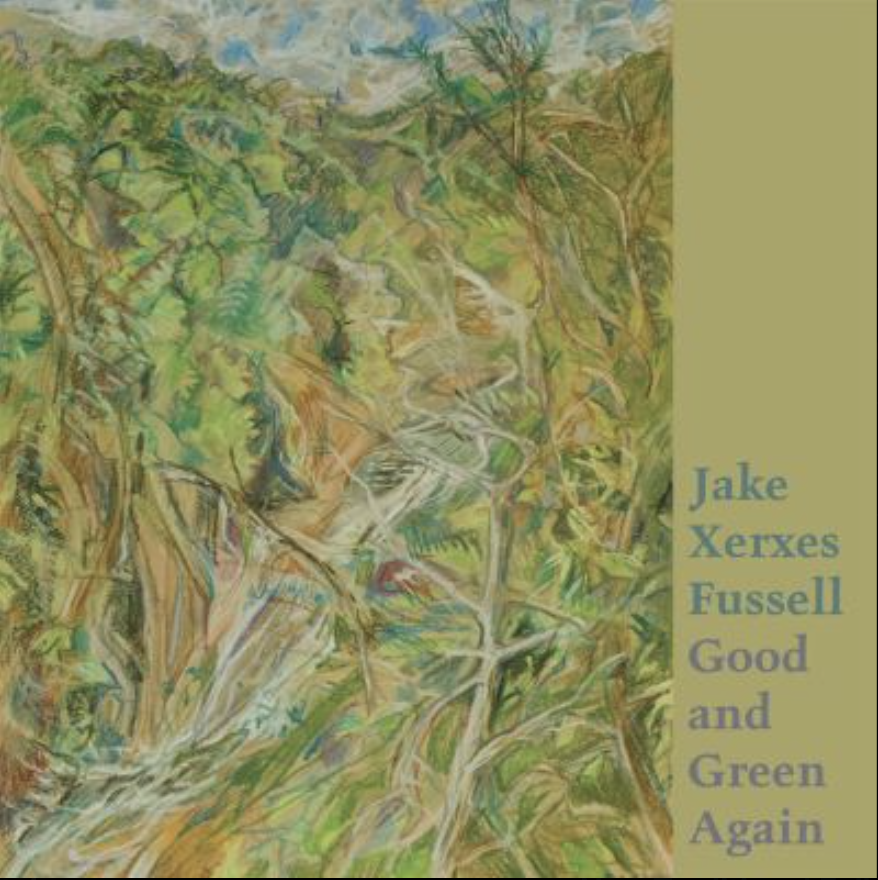Quando, poco più di un mese fa, precisamente il 12 luglio 2025, ho pubblicato la mia classifica dei migliori brani del 2021 (in leggerissimo ritardo!) vi avevo anche esortato a non sottovalutarmi, perché il 2022 era a buon punto.
Facciamola breve: la classifica del 2022 è qui. Ancora una volta 36 brani (ormai mi sembra un format consolidato, almeno fino a prova contraria), elencati dall’ultimo al primo, sapendo bene che la posizione in classifica è un giudizio spesso di massima e che qualche slittamento all’interno dell’ordine non ne pregiudicherebbe il senso, il divertimento che ho provato nella selezione e che – spero – possa provare qualche ascoltatore di passaggio. Dalla mia lista del 2022 emerge chiaramente una sorta di disgelo dopo gli anni più duri del Covid: canzoni ancora fragili, timorose, ma nelle quali la speranza, l’amore, il desiderio di tornare a credere nelle relazioni si affacciano con forza.
Un’avvertenza: per la classifica del 2023 ci sarà da aspettare un po’ di più.
36 – The Smile – Skrting on the surface (A Light for Attracting Attention)
Primi della lista, cioè ultimi dei primi, arrivano The Smile, il nuovo progetto dei già Radiohead Thom Yorke e Johnny Greenwood, coadiuvati da Tom Skinner alla batteria. La loro musica è per certi versi perfetta: intelligente, sperimentale, di grande atmosfera, e tuttavia pop nel senso buono, quello di una melodia riconoscibile, non cannibalizzata dalla troppa intelligenza. E tuttavia l’operazione, molto acclamata, a me suona un po’ freddina, e quindi se ne sta qui, presente fra i big, ma nelle retrovie.
35 – Alt-J – Hard Drive Gold (The Dream)
Gli Alt-J sono un gruppo inglese che fonde pop, folk, un po’ di tecnologia, qualcosa di beatlesiano (come molti, e lo vedremo). Non so se questo brano è il primo a occuparsi di criptovalute (“gimme that gold / straight into my hard drive”), ma di certo con il suo andamento frenetico sorretto da un groove di basso e batteria e il suo testo ultracontemporaneo (“Don’t be afraid to make money boy”) ha qualcosa di accattivante che rimane in testa.
34 – The Black Keys – Baby I’m Coming Home (Dropout Boogie)
Che cosa ci fanno i Black Keys in una posizione così bassa? Intendiamoci: il brano è piacevole, una specie di southern blues alla ZZ Top con un cantato che ricorda i Beatles (eccoli! Non sarà l’ultima volta) nell’armonia vocale e un assolo di chitarra che più fat (termine inequivocabile per i chitarristi, specie se di rito gibsoniano). È la formula che inizia a sembrarmi un po’ pigra: Dan Auerbach ha dimostrato di saper produrre il suo swamp-hard-boogie in dosi industriali e sempre con risultati gradevoli: è che da un fuoriclasse come lui, che ogni anno produce cento dischi di altri, ci aspettiamo un po’ di più.
33 – Tongo Barra – Vieux Farka Touré & Khruangbin (Ali)
È tradizione, e direi ottima tradizione, che ogni anno nella classifica dei brani migliori ce ne sia uno proveniente dall’Africa. Nel 2020 c’erano i Songhoy Blues, quartetto quasi hard rock del Mali, nel 2021 Mdou Moctar, un Touareg proveniente dal Niger. Quest’anno abbiamo Vieux Farka Touré che pur chiamandosi Vieux (cioè vecchio) è il figlio del celeberrimo Ali Farka Touré, chitarrista e icona della allora “world music”. Per questo album dedicato al padre e conformemente intitolato Ali, il giovane Vieux si fa accompagnare dai Khruangbin che, a dispetto del nome esotico, sono un trio texano. Il brano si regge su un riff di chitarra, un rullante asciutto e soprattutto un basso che sembra parlare, e cresce col tempo, quasi stratificandosi intorno al suo semplicissimo groove.
32 – Too Far To Be Gone – Shemekia Copeland (Done Come Too Far)
Anche Shemekia Copeland è figlia di un musicista famoso, il chitarrista della Louisiana Johnny Copeland; in proprio è una delle più grandi cantanti blues in attività, con un timbro potente e pulito. Ma drizzate bene le orecchie: se questo brano entra in classifica, molto del merito si deve alla collaborazione con un altro chitarrista della Louisiana, il mago della slide Sonny Landreth, che qui presta a Shemekia il suo tono saturo e il suo fraseggio denso e inconfondibile.
31 – Black Widow – Nikki Lane (Denim & Diamonds)
Nikki Lane è una ragazza che viene dalla South Carolina ed è arrivata fino a collaborare con Lana Del Rey su “Chemtrails over the Country Club” (ehi, dove l’abbiamo appena incontrata?). Il suo punto di partenza è il country ma, come si capisce dalla prima nota, nel suo country c’è molto rock, spigoloso e puntuto. Verrebbe da dire che alla chitarra ci potrebbe quasi essere un giovane Keith Richards a forgiare riff, ma la realtà è ben più estrema: alla produzione c’è nientemeno che Josh Homme dei Queens of the Stone Age, che si è portato dietro un po’ di suoi compagni di band, ed ecco spiegati (almeno in parte) i muscoli di questo brano.
30 – Hold Me Slow – The Delines (The Sea Drift)
La carriera di Willy Vlautin non è facile da seguire. Ha fondato i Richmond Fontaine, un gruppo caratterizzato da un folk cupo e drammatico, fatto di storie vere e dure, ma ha anche pubblicato numerosi romanzi di successo e in tutto questo ha trovato il modo di creare un progetto collaterale, i Delines appunto, che sono il punto d’incontro fra il suo storytelling affilatissimo e la voce della sua musa Amy Boone, cantante texana, in cui evidentemente ha trovato lo strumento ideale per dare vita ai suoi racconti. Come in questa “Hold Me Slow”, in cui descrive con una precisione quasi dolorosa lo stato d’animo di una donna che desidera lasciarsi andare ma che al contempo ha paura di mostrarsi disarmata: “Sono stata stanca e sola, ho sofferto, lo devi sapere”.
29 – I Am The Moon – Tedeschi Trucks Band (I Am the Moon – I. Crescent)
La Tedeschi Trucks Band è una corazzata del rock-blues capitanata dai coniugi Susan Tedeschi (cantante e chitarrista) e Derek Trucks, virtuoso chitarrista slide, figlio di un membro della Allman Brothers Band (Butch Trucks) ed erede designato, se non reincarnato, del loro prodigioso chitarrista Duane Allman. Nel 2022 la band ha realizzato una quadrilogia di album ispirati al poema sufi del dodicesimo secolo Layla and Majnun, cui fra l’altro si era rifatto anche Eric Clapton per quello che resta forse il suo lavoro migliore (“Layla”, appunto). Qui siamo nel primo album e Susan duetta con il tastierista Gabe Dixon in una ballatona sull’annoso tema degli innamorati divisi dal destino, mentre gli strumenti fanno il loro ingresso un po’ alla volta, con i fiati che preparano l’ingresso della slide guitar protagonista del crescendo finale, in un clima quasi da musical.
28 – These Are The Good Old Days – Courtney Marie Andrews (Loose Future)
Courtney Marie Andrews è una giovane (1990) cantautrice dell’Arizona emersa nei circuiti indipendenti all’inizio degli anni ’10 e consacratasi con un album del 2018. La sua musica nasce nel folk e nel country, ma ha una freschezza e un’orecchiabilità tutta indie-pop e ritornelli che viene voglia di canticchiare. Come in questa “Good Old Days” dove, quasi a sorpresa se pensiamo al clima cupo e ansioso di questi anni immediatamente post-pandemici, descrive una serata dolce e romantica, da godere in ogni minuto, da ricordare, magari da farci una canzone: “These are the good old days / don’t let the times slip away”.
27 – The Devil & Mister Jones– Spoon (Lucifer On the Sofa)
Voi li conoscevate gli Spoon? Io no. Eppure sono in circolazione dall’inizio degli anni ’90, guidati dal cantante e chitarrista Britt Daniel e dal batterista Jim Eno (nessuna parentela con Brian): nati come un gruppo post-punk, hanno via via incorporato nella loro musica elementi pop, soul, fino al suono texano del loro stato natio, ricevendo qualche buon riscontro commerciale. Questo brano, con la sua ritmica di chitarra, i cori soul e i riferimenti satanici, sembra quasi un outtake dei Rolling Stones di Tattoo You.
26 – Geraldene – Miranda Lambert (Palomino)
E a proposito di influenze, incroci e somiglianze, questa “Geraldene” è chiaramente un tributo alla leggendaria “Jolene” (che infatti viene citata nel testo), la canzone con cui Dolly Parton supplicava la rivale di non prendersi il suo uomo per capriccio. Miranda Lambert viene dal Texas ed è riuscita a conciliare la sua devozione ai sacri testi del country con un’immagine indipendente e ribelle. Qui si parte con un riff di chitarra che sembra venire dagli ZZ Top e subito dopo la voce di Lambert fa la sua comparsa, con un tono più minaccioso che supplichevole: “I’m the only bitch in the band”, avvisa la rivale senza troppi giri di parole.
25 – Rednecks – Lee Bains + The Glory Fires (Old-Time Folks)
Lee Bains e la sua band provengono dall’Alabama e suonano una musica che sarebbe facile etichettare come country-rock tradizionale. In realtà nel loro impasto sonoro c’è molto di più, dalla tradizione sudista a una certa insofferenza quasi punk. Ma sono i testi che ci obbligano a soffermarci: questa “Rednecks” (i redneck sono i bianchi conservatori del sud, così detti perché portando i capelli con la sfumatura alta hanno il collo scottato dal sole) sembra un messaggio rivolto ai Democratici di New York e della California che, con le migliori intenzioni, non hanno capito l’America profonda consegnandola al peggior presidente della storia: “Non chiamarli spazzatura, amico, loro sono la mia gente / Tu non sei meglio di loro o di nessun altro / Quando loro arrancano tu arranchi con loro / Se vai contro la mia gente tu vai contro te stesso”. La migliore analisi del voto del 2024, con due anni di anticipo.
24 – Like the Thunder – Joan Shelley (The Spur)
Viene dal Kentucky Joan Shelley. Ha una voce calda e duttile, che sembra sapersi adattare a qualsiasi costruzione sonora e il suo repertorio tiene insieme il folk americano con quello inglese, da cui ovviamente il primo proviene. Sarà un caso, ma questa “Like the Thunder” è già la terza canzone cantata da una donna su un amore felice, dopo quelle dei Delines e di Courtney Marie Andrews, come se dopo tanta ansia e solitudine negli anni della pandemia qualcosa si stesse finalmente sciogliendo nei rapporti fra le persone.
23 – Wet Dream – Wet Leg (Wet Leg)
Cambiamo completamente atmosfera dopo tanta America interna e sudista, e ci trasferiamo dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, ma non a Londra, a Manchester o a Glasgow. È dall’isola di Wight (famosa per un festival musicale) che provengono le Wet Leg, gruppo capitanato da Rhian Teasdale ed Hester Chambers. le due ragazzacce isolane si conoscono da una decina di anni quando decidono di tentare la sorte come band. E catapultate da un paio di singoli a effetto si trovano al primo posto in UK e con un Grammy per il migliore album alternativo. La musica è un pop tagliente venato di punk, semplice e diretto: le due leader giocano sulla loro immagine un po’ sexy e un po’ ironica e, coadiuvate da tre musicisti (basso, batteria e tastiere), danno vita a una musica fresca e contemporanea, divertente e orecchiabile, dai testi maliziosi e sarcastici, diretti in questo caso a un malcapitato ex, il tutto in poco più di due minuti. Da seguire.
22 – Red Moon – Big Thief (Dragon New Warm Mountain I Believe In You)
Torniamo di corsa in America e in particolare a Brooklyn con i Big Thief di Adrianne Lenker e l’album con il titolo più lungo di questa classifica. Dai primi accordi di chitarra sembra di trovarsi in “Comes a Time” di Neil Young e il violino che si aggiunge subito dopo contribuisce a un’atmosfera poco brooklyniana e molto country. E in effetti il brano sembra una riflessione profonda sulla necessità di staccare da tutto e di rifugiarsi in campagna, proprio come suggeriva lo stesso Neil Young, questa volta in “Out on the Weekend”: “Guadagna guadagna, corri per la grande città, brucia le suole sull’asfalto bollente, voglio lasciare questa città, c’è qualcuno da incontrare”.
21 – I Dream of Sleep – Sloan (Steady)
Gli Sloan sono un quartetto canadese in circolazione dai primi anni ’90 con il suo pop-rock sempre impeccabilmente confezionato, forse troppo pop e troppo poco “qualcos’altro di moda” (punk? Grunge? Elettronica?) per emergere nel mare magnum della musica nordamericana. Ma gli Sloan non se ne sono preoccupati troppo e hanno continuato a produrre album piacevoli e curati. Qui il punto di partenza è una vivace ballata country dedicata al sonno, ma si capisce bene che per i canadesi di Halifax (in questo simili ai Wilco) il country è solo un pretesto, un punto di partenza, un gioco per mettere in scena armonie vocali, melodie, suoni di chitarra dalla perfezione cristallina.
20 – Hard Working Man – Marcus King (Young Blood)
Il giovane veterano (è del 1996, ma sembra in giro da sempre) Marcus King si potrebbe frettolosamente definire un chitarrista blues per l’attitude e per i suoi assoli saturi spremuti da una Gibson Les Paul. Ma in realtà nella sua musica si può trovare molto di più, dal folk, al rock sudista (è pur sempre della South Carolina). E questa “Hard Working Man”, con la sua intro fatta di power chords, ha un piacevole gusto di hard rock anni ’70 che ricorda quasi gli AC/DC.
19 – Friday Night – Beth Orton (Weather Alive)
La formula che unisce l’immediatezza del folk con il senso di straniante contemporaneità dell’elettronica (folktronica?) ha tenuto banco a lungo negli anni ’10 di questo nuovo secolo. E se usata bene può conferire calore ai suoni sintetici e modernità a quelli acustici. È quello che fa Beth Orton, nata in Inghilterra nel 1970, in questa notturna (fin dal titolo) “Friday Night”: qui è la sua stessa voce a portare calore e umanità su un tappeto elettronico, mentre i testi sembrano descrivere un doloroso ritorno alla vita, ennesimo indizio del fatto che il Covid, con il suo isolamento forzato, sta finalmente passando: “Avevo dimenticato che avessimo ossa / Avevo dimenticato che potessimo provare sentimenti / Avevo dimenticato che ci saremmo svegliati / E che tutto sarebbe stato vero / E che tutto sarà vero”.
18 – Big Troubles Come In Through a Small Door – Jeb Loy Nichols (The United States of the Broken Hearted)
Bel tipo, questo Jeb Loy Nichols, americano, nato nel 1958, trasferitosi a Londra e poi addirittura in Galles, scrittore e artista visuale oltre che, naturalmente, musicista. La sua particolarità è quella di combinare gli stili classici degli USA, dal blues al folk al soul, con le sonorità caraibiche e giamaicane. Questo brano dal titolo lungo e filosofico è una sorta di blues ballad, cantata con voce roca su un bell’arrangiamento jazz in cui il protagonista è un flauto che sembra arrivare da un’epoca molto lontana.
17 – Lessons Learned – Robert De Leo (Lessons Learned)
Robert De Leo non è altri che il bassista degli Stone Temple Pilot, corazzata del rock alternativo anni ’90, sopravvissuta a numerosi alti e bassi. Nel frattempo, i fratelli De Leo (Dean è il chitarrista) sono stati costretti a inventarsi numerose attività extra-curriculari per riempire i lunghi periodi vuoti. Questa è però la prima volta che Robert si impegna in un album solista. Le sonorità sono quelle del folk-rock della California degli anni ’70: e, a parte che la canzone inizia con le parole “Comes a time”, sembra sempre che David Crosby o James Taylor possano spuntare fuori da un momento all’altro per cantare una seconda voce.
16 – Wondering Why – The Red Clay Strays (Moment of Truth)
I Red Clay Strays sono una delle migliori novità del rock sudista: vengono dall’Alabama, sono guidati dal cantante/chitarrista Brandon Coleman e questo è il loro primo album. Non solo: questa ballatona soul è il primo singolo dell’album e quello che li ha resi irresistibilmente famosi negli Stati Uniti. Ed è proprio la voce di Brandon Coleman, che a tratti ricorda Otis Redding quando si arrampica sulle note più alte, a trainare il brano – una canzone d’amore felice e senza ombre, tanto che lui non può fare a meno di “wonder why”, di chiedersi perché gli sia andata così bene – verso il finale.
15 – Where Have All the Brave Knights Gone – Kula Shaker (1st Congregational Church of Eternal Love (And Free Hugs))
Ai Kula Shaker, un gruppo inglese di grande successo nella seconda metà degli anni ’90, piace giocare con le parole: lo si capisce dal titolo della canzone e ancor più dal titolo dell’album. Ma quasi tutto, nella loro musica, è giocoso e ironico: lo è in particolare il recupero di un’Inghilterra scomparsa (o forse mai esistita), sul modello dei Kinks che già nel 1968 ironizzavano sulla nostalgia con quel capolavoro di humour e di malinconia che è “The Village Green Preservation Society”. Dal punto di vista musicale, il brano parte come una ballad dylaniana con un Hammond che soffia poderoso, salvo arricchirsi di armonie vocali più inglesi nella seconda strofa. Nel complesso, un esercizio forse non inedito ma riuscito e divertente.
14 – BIRTHDAY – The Lumineers (BRIGHTSIDE)
I Lumineers non saranno i Beatles (anche se gli accordi di piano e le rullate di batteria nella strofa sono una delle cose più beatlesiane mai sentite), ma hanno un gusto innegabile per la melodia. Nella loro semplicità, i singoli del gruppo di Denver sembrano fatti per stamparsi in mente ed essere cantati in coro ai concerti: e di fronte a tanta maestria non si può che complimentarsi, malgrado il sospetto di un pizzico di furbizia rimanga. Non fa eccezione questa BIRTHDAY, con un ritornello perfetto per farci piangere e ridere, magari montato sotto un video di immagini di vita un po’ sgranate il giorno di un compleanno importante, che siano diciott’anni oppure ottanta.
13 – Love Farewell – Jake Xerxes Fussell (Good and Green Again)
Jake Xerxes Fussell è un cantante-chitarrista della Georgia, ma prima ancora è un ricercatore delle tradizioni musicali folk e blues che ha viaggiato, ha studiato, ha ascoltato. “Love Farewell”, una delicata marcia appoggiata su una chitarra acustica, è un traditional sul tema antico e purtroppo sempre attuale del soldato che parte per la guerra e saluta la sua amata. Il testo è semplice, quasi puerile (“Oh my love, you know I love you / Nothing on this earth, that I love like I love you”, caso mai ci fossero dubbi), come si conviene a parole che provengono da una matrice veramente popolare. A dare una mano a Jake, un ospite d’eccezione: Bonnie Prince Billy, grande capo della musica acustica d’autore, che interviene (troppo poco: bisogna stare attenti) con la seconda voce a partire dal secondo ritornello.
12 – Unconditional I (Lookout Kid) – Arcade Fire (WE)
Tornano, dopo una pausa di cinque anni, gli Arcade Fire, gruppo di Montreal beniamino di critica e pubblico. Lo fanno con bel un disco a tema, diviso in due parti intitolate rispettivamente “I” e “WE”, dedicato evidentemente ai rapporti fra le persone. In questo brano, che parte leggero, anch’esso sostenuto da una chitarra acustica (quante chitarre acustiche!), e va crescendo nel finale, il leader Win Butler si rivolge a suo figlio (avuto con la compagna di band Régine Chassagne), cui rivolge una serie di teneri consigli sulla vita. O forse parla a sé stesso. O a tutti noi.
11 – Little Freak – Harry Styles (Harry’s House)
Se Harry Styles trasforma in oro ogni cosa che tocca, dalla sua carriera giovanile con gli One Direction a quella solista attualmente in corso, passando per una partecipazione al film Dunkirk di Christopher Nolan, qualcosa ci deve essere e non lo scopriamo certo adesso. Di certo questa ballata “confidenziale” è un gioiellino di languido pop californiano (quasi una versione maschile di Lana Del Rey) in cui strumenti digitali e analogici (fra cui una chitarra classica) si mischiano con eleganza, che la voce di Harry tiene a bada con stile. Il testo unisce dolcezza, rimpianto, nostalgia, distacco: “I’m not worried about where you are / Who you will go home to / I’m just thinking about you”.
10 – I Love You – Fontaines D.C. (Skinty Fia)
Si può pensare a un titolo più banale di “I Love You”? No. Ma i dublinesi Fontaines D.C. – apprezzati ospiti di queste classifiche fin dal loro debutto del 2019, “Dogrel” – sono fra i pochi che possono permetterselo: il loro linguaggio testuale e musicale è così diretto, abrasivo, impietoso, che niente nelle loro mani può apparire stucchevole. Se tutta la produzione della band affonda le sue radici nel rapporto con l’Irlanda e con Dublino, in questo disco il legame con le radici è il centro dichiarato: lo stesso titolo, in gaelico, sembra essere un’imprecazione che ha a che fare con un mitico cervo gigante e, fuor di metafora, con la perdita di identità dell’Irlanda contemporanea. E anche questa canzone – tre strofe piacevolmente pop-rock intervallate da due “recitativi-rap” scanditi con rabbia – è esplicitamente dedicata alla loro terra, amata e odiata: “This island’s run by sharks with children bones in their jaws”.
9 – How – Marcus Mumford & Brandi Carlile (self-titled)
Dopo avere guidato con i Mumford and Sons – insieme ad altri apprezzati colleghi come i Bon Iver e i Fleet Foxes – la stagione del neo-folk di inizio millennio, Marcus Mumford torna con un bell’album solista. In questa “How”, una delicatissima ballata costruita su un arpeggio di chitarra cui poco a poco si aggiunge un piano, l’arma segreta è la seconda voce di Brandi Carlisle, che abbiamo incontrato nella classifica del 2021. La canzone parla di perdono (“But I’ll forgive you now”, dice il ritornello), ma la sensazione che dietro quel “but” ci sia molto dolore. Il risultato, in ogni caso, è emozionante.
8 – Can I Take My Hounds to Heaven? – Tylers Childers (Can I Take My Hounds to Heaven?)
Torniamo in America dopo un po’ di Inghilterra. Tyler Childers è il nuovo erede al trono dell’alternative country, una specie di fratellino minore di Sturgill Simpson con cui condivide le origini in Kentucky e che ha prodotto il suo album del 2017, “Purgatory”. Qui Tyler registra uno stesso set di otto canzoni in ben tre versioni. Un bel gioco, reso possibile dalla musica in formato digitale (chi avrebbe comprato il triplo vinile?), forse non necessario. Come che sia, il brano che dà il titolo all’album, qui nella Hallelujah Version, è una ballata quasi soul nella quale Tyler chiede di potersi portare i cani da caccia in paradiso, altrimenti è disposto ad andare all’inferno con i suoi amici. Il tutto fra chitarre, organo Hammond e con la inconfondibile voce fragile e nervosa di Childers, che sembra sempre sul punto di spezzarsi.
7 – She Still Leads Me On – Suede (Autofiction)
Chi si rivede! I Suede, guidati dall’androgino, ambiguo, affascinante Brett Anderson, esplosi nel 1993 con un pugno di singoli decadenti e perfetti. Certo, pensare che Anderson, che all’inizio della sua carriera cantava “So Young” comunicando un irrefrenabile senso di possibilità, di pericolo e di promiscuità, è nato nel 1967 e ha pertanto quasi sessant’anni, fa un po’ impressione. Tuttavia il gruppo (che dei membri originari ha purtroppo perso il geniale chitarrista, Bernard Butler) è in buona forma e il disco è bello. E quando in questo brano, dedicato nientemeno che alla sua mamma, la voce di Brett sale in falsetto sulla parola “leads”, tutto sembra ancora “so young”.
6 – Mercury – Andrew Leahey & The Homestead (American Static, Vol. 2)
Dei molti cantautori americani recensiti in questa playlist Andrew Leahey è probabilmente il meno noto, ma non per questo il meno interessante. Innanzitutto per la sua formazione: solidi studi musicali, la laurea e il lavoro da giornalista musicale che lo ha portato a collaborare con testate di primo piano. Poi una difficile battaglia con un tumore al cervello, un’operazione molto complicata, il ritorno alla salute (e alla musica). Musicalmente, Leahey è un fedele dell’heartland rock, con particolare predilezione per Springsteen e Petty. Questo album è la seconda parte di un progetto volto a esplorare la grande ricchezza di sfaccettature che la musica americana sa offrire anche quando finge di restare all’interno di un genere. E la voce di Andrew Leahey merita davvero di essere seguita.
5 – An Alien In Minneapolis – Ondara (Spanish Villager No. 3)
Ondara è nato a Nairobi, in Kenya, e ha sviluppato una precoce passione per la scrittura di poesie e canzoni, influenzato da numerosi musicisti rock e soprattutto da Bob Dylan. Come il titolo di questa canzone lascia intuire, si è trasferito a Minneapolis, dove ha imparato a suonare la chitarra e ha iniziato a esibirsi negli “open mic” in piccoli locali e poi via via in contesti sempre più importanti. La sua musica non risente particolarmente delle origini africane: il suo modello dichiarato è il folk-rock americano. In questo brano dichiara tutta la sua estraneità, ma sembra prendersela con qualcuno/a che gli ha sottratto amici e dischi vintage, alla cui famiglia non è mai piaciuto, inclusa una sorella che ha venduto la collanina che lui aveva comprato in Giappone. Un addio senza sconti, un risentimento aspro e diretto, il più dylaniano dei sentimenti: manca solo che dica: “It ain’t me, babe”.
4 – Please Be Wrong – Wilco (Cruel Country)
“I love my country/Stupid and cruel”, canta a un certo punto dell’album Jeff Tweedy, il leader dei Wilco: e come spesso accade ai grandi artisti, sembra avere già visto quello che succederà a distanza di un paio d’anni. Ma “Cruel Country” è anche un album country inteso come genere, che riporta i Wilco ai loro esordi, se non addirittura al precedente gruppo di Jeff, gli Uncle Tupelo. Spazio alla steel guitar, quindi, anche se quando si ha a che fare con quel grande artigiano sonoro di Tweedy le cose non sono mai così semplici e il suo country (inteso come genere) è più sfaccettato del previsto. E quando – dopo tre soli minuti – il brano si conclude, resta il desiderio di sentire ancora un po’ di quella melodia morbida e intelligente.
3 – Fair Annie – Bonny Light Horseman (Rolling Golden Holy)
Anche se il loro nome fa pensare immediatamente a Bonnie “Prince” Billy (all’anagrafe Will Oldham), già incontrato in questa classifica, questo mini supergruppo indie folk ha in realtà un altro progenitore illustre: nientemeno che Justin Vernon (noto ai più come Bon Iver), molto amato da chi scrive e citato nella classifica del 2021. È stato Justin, infatti, a spingere i tre ragazzi (Anaïs Mitchell, Eric D. Johnson e Josh Kaufman) a esibirsi in un festival da lui stesso organizzato, complice anche la comune provenienza da Eau Claire, Wisconsin. Il brano è un delizioso intreccio di strumenti a corda (chitarre e banjo) e soprattutto delle splendide voci di Eric D. Johnson e Anaïs Mitchell. Il tema è ancora una volta quello dell’addio fra due amanti e potrebbe stare nello stesso songbook di “Love Farewell” (vedi sopra): con la dolce ingenuità dei suoi testi sembra un traditional (e forse lo è in parte).
2 – Strange – Thomas Dollbaum (Wellswood)
Chi è Thomas Dollbaum? Confesso che, a causa dell’assonanza con Thomas Dolby e di quella desinenza germanica “baum” (albero, in tedesco), temevo di trovarmi davanti a una cosa pericolosamente fredda e techno. E invece no: Thomas è originario della Florida e vive a New Orleans, dove si era trasferito per seguire un corso di poesia. Ma soprattutto scrive e canta brani che potremmo definire di cantautorato rock (a me ha fatto venire in mente Joseph Arthur), con un gusto particolare per i temi profondi e le storie di vite difficili, una voce acuta che ricorda Neil Young, ma un po’ bofonchiata e sepolta nel mixaggio, come se non volesse apparire troppo. Thomas Dollbaum è al suo primo disco: seguiamolo con affetto.
1 – Big Time – Angel Olsen (Big Time)
“Big Time” è un’espressione che significa “molto”, ma in un modo più informale ed enfatico che potremmo forse tradurre con “alla grande”. “Big Time” è la meravigliosa title-track di un album di Angel Olsen, una cantante che ha iniziato la sua carriera come corista di Bonnie “Prince” Billy (di nuovo!): una sorta di valzer lento, dai toni country, che sembra venire dal passato e che descrive la nascita di un grande amore (in questo caso con la sceneggiatrice Beau Thibodeaux). Se il brano è perfetto nella sua semplicità, la voce di Angel Olsen ha qualcosa di magico, con il suo timbro quasi noncurante, il suo falsetto, la sua capacità di ridurre a tratti il canto a un puro soffio, come se la voce le cedesse improvvisamente. A rendere il tutto ancora più struggente e affascinante, questa versione – pubblicata dopo l’album – con il (anche lui) già citato Sturgill Simpson, nuovo padre nobile della musica americana, che alla magia di Angel contrappone il suo timbro baritonale. Fare di meglio era difficile.