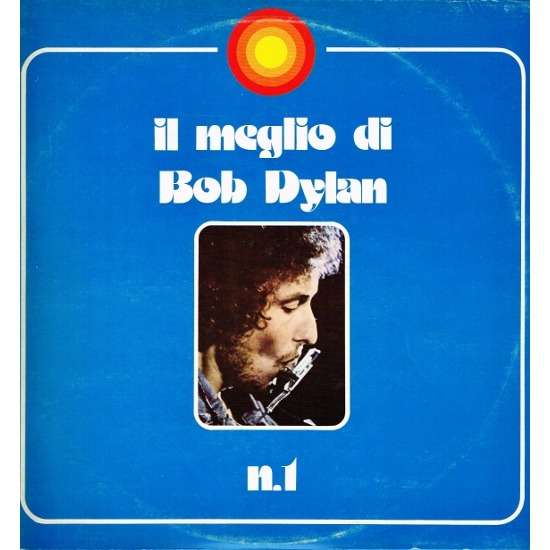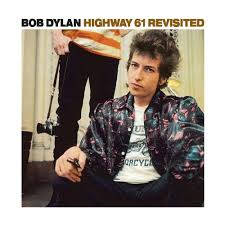Non me ne vogliano Beatles (che pubblicarono addirittura due dischi, e che dischi: Help e Rubber Soul) e Rolling Stones, Who o chi volete voi. Non faccio neanche finta di pensarci: il mio album del 1965 è “Highway 61 Revisited”. E, in fin dei conti, iniziare con His Bobness mi sembra, più che doveroso, semplicemente inevitabile.
Dimenticavo. Siete al cospetto di un ambizioso e probabilmente fallimentare tentativo: quello di recensire un disco per ogni anno di vita (mio). Minimo cinquanta, quindi, massimo non si sa. I miei Nifty Fifty, i meravigliosi cinquanta (e magari un po’ di più, se la salute tiene…). Tempi previsti? Dato non disponibile.
Ultima nota metodologica: cercherò di essere obiettivo, finirò per essere parziale, personale, passionale, fortemente prevenuto. Se volete la recensione seria, leggetela su Allmusic o su Uncut, come peraltro faccio anch’io quando voglio capirci qualcosa.
Allora, via.
Dovete sapere che quello che abbiamo fra le mani è il più grande disco di sempre. O, meglio, il disco che si apre con quello che la rivista Rolling Stone ha definito il miglior brano di sempre: “Like a Rolling Stone” (che ci sia un conflitto di interessi?). Un capolavoro effettivamente inspiegabile, che ridefinisce tutto. Chi l’ha arrangiato? Perché è venuto così? Sarà vero che Al Kooper ha suonato l’organo in sala di registrazione perché lui che era un chitarrista si è vergognato di suonare la chitarra davanti a Mike Bloomfield, inventando ipso facto e per errore il ruolo dell’Hammond nel rock?
Fatto sta che con quei due colpi di batteria (direi un rullante e un tom) inizia il rock americano come lo conosciamo oggi. Senza, non avremmo quasi niente. Non solo Tom Petty e Bruce Springsteen, e tantissimi altri, che quel “format” di canzone rock americana hanno dichiaratamente fatto proprio, ma forse neanche… Dite un nome: non ci sarebbe. Lo dimostrano i Rolling Stones che, con semplicità geniale (c’è da chiedersi, anzi, perché non lo abbiano fatto prima) nel 1995 ne realizzano una cover (“la” cover) che chiude il cerchio: il perfetto pezzo rock suonato dalla perfetta rock band, l’America e l’Inghilterra, il solista e il gruppo. E, nelle mani di Keith Richards e soci, “Like a Rolling Stone” suona come un pezzo dei Rolling Stones, anzi, di più, come il pezzo rock definitivo e inappellabile. Il millennio è finito, ragazzi: andate pure a casa.
Comunque, tranquilli: non ho intenzione di tediarvi con la rivoluzione del Dylan “elettrico”, stigmatizzata dai folkster duri e puri, eccetera eccetera, che è probabilmente il pezzo di cultura popolare del Novecento più trattato al mondo insieme allo sbarco sulla luna, all’assassinio di Kennedy e al match Alì-Foreman a Kinshasa. Veniamo a noi, piuttosto: a me e al capolavoro.
Come sono entrato in possesso di questo disco? Per ovvie ragioni anagrafiche, intanto, non l’ho scoperto in diretta: in quell’agosto del ’65 avevo sette mesi. Per i biografi: il primo album di Dylan di cui ricordo nei dettagli l’uscita fu “Slow Train Coming” (1979), con Mark Knopfler alla chitarra, trasmesso integralmente da Radio Popolare e da me gioiosamente registrato; qualche ricordo più vago ce l’ho di “Street Legal” (1978) o forse del singolo “Changing of the Guards”. Prima, niente.
O, meglio: prima c’era forse una vaga idea di Dylan, comunque asincrona, limitata al Dylan “di protesta” degli esordi, tramandata attraverso il mainstream anche scolastico. Funziona (funzionava?) così: alle medie impari a suonare un po’ la chitarra e in qualche modo ti arriva un foglio con le parole e gli accordi di “Blowin’ in the Wind”. Il mio primo disco di Dylan è stato una raccolta italiana di colore azzurro cielo con tutti i classici del primo periodo: ce l’ho ancora e di fianco al titolo di ogni brano c’è scritto il relativo numero di pagina sul songbook, il librone con tutti gli spartiti.
Intanto, però, mi guardavo intorno. Ero un “bootlegger” abbastanza maniacale: sapendo bene che – ars longa, vita brevis, pecunia scarsa – non sarei riuscito a comprare che una piccolissima parte dei dischi che mi interessavano, registravo su cassetta tutto quello che riuscivo a trovare. Lasciavate un disco (decente) in giro e io lo registravo su una Basf C-60, spesso non esattamente di primo pelo (immaginatevi la qualità). Le Tdk al ferro-cromo o come si diavolo si chiamava sarebbero arrivate dopo.
Però. Avendo una sorella più grande, che all’epoca aveva un figlio piccolo e amiche con analoghi figli piccoli, ero un babysitter piuttosto richiesto. Ero pagato per arrivare, attendere che il piccino si addormentasse (nessuno pretendeva grandi prestazioni ludo-pedagogiche: all’epoca i bambini erano trattati più come bambini e meno come divinità imperscrutabili), e poi (molto in teoria) studiare, (più frequentemente) leggere, ascoltare musica, talvolta fantasticare sulla padrona di casa, alla fine dormire sul divano.
Così, a casa di “clienti” intelligenti, una di quelle belle case un po’ disordinate ma piene di vita e di cultura dei nati negli anni fra ’40 e ’50, composte da una cucina colorata, una camera da letto spartana con un telo indiano come copriletto e per tutto lo spazio che restava da scaffali con i libri e i dischi giusti, ho scoperto il capolavoro, che all’epoca mi parve addirittura un po’ negletto, dimenticato in un angolo (per loro, che invece erano sincroni, non era una novità, era lì da sempre). «Posso prenderlo per registrarlo?». Non sapevo che cosa aspettarmi, ma c’era scritto “Bob Dylan” e tanto mi bastava. Quindi, sì: il più bel disco della storia adesso ce l’ho su tutti i supporti che volete, ma per anni l’ho ascoltato e riascoltato su una cassetta, registrata (male) da me, su un registratore portatile Grundig (a proposito: sono stato a Berlino, poco fa, e ho visto la pubblicità della Grundig. Esiste. Come mai da noi è sparita?). Un sacrilegio.
Eppure. Portavo con me il piccolo Grundig quando facevo il bagno e tra i vapori dell’acqua calda mi inebriavo di quelle canzoni soggettivamente (mica li capivo tanto, i testi di Dylan) e oggettivamente (mica si capiscono tanto, i testi di Dylan) incomprensibili, enigmatiche, affascinanti, con quella voce che sembrava sempre risentita, quelle chitarre che sferragliavano, quell’armonica acuta che quasi ti faceva male, quell’organo che sotto a tutto il casino stendeva un tappeto morbido che sembrava l’unica possibile via di uscita dal caos.
Che pezzi! Detto della perfezione di “Like a Rolling Stone”, potremmo dire del tono ironico, surreale e minaccioso insieme della stessa “Highway 61 Revisited”: Dio che si rivolge ad Abramo chiamandolo Abe, col diminutivo, come se fossero amici, ma Dio si sta un filo spazientendo per questa storia di Isacco, per cui sembra voler dire “ti chiamo ancora una volta col diminutivo in nome dell’antica amicizia, però è l’ultima” e infatti gli dice “fai come vuoi, ma la prossima volta che mi vedi inizia a correre”. Di “Ballad of a Thin Man”, che – un po’ come il film “Il Laureato”, che guarda caso è del 1967 ma il libro è del 1963 quindi la media fa ’65 – fa implodere la società americana, mettendoci 5 minuti e 59 secondi (ma probabilmente bastano i primi 30 secondi): “Something is happening, but you don’t know what it is: do you, mr Jones?. Il mondo di Mr Jones va a pezzi, ma lui, il buon borghese della classe media, non riesce neanche a capire che cosa succede.
“Keeping up with the Joneses” è un’espressione usata da chi studia i consumi, per indicare quell’effetto di emulazione dal basso che porta alla crescita dell’economia. I nostri vicini, i Jones, hanno cambiato le tende? Cambiamole anche noi. I Jones sono il ceto medio che si è fatto il mazzo, ha conquistato il suo piccolo benessere e adesso arriva questo hipster spettinato con la voce sgraziata a dir loro che è tutto inutile, perché tanto il mondo è già cambiato un’altra volta. Dove solo un anno prima “The Times They Are A-Changing” era un avvertimento didascalico (“your sons and your daughters are beyond your command”) e per ciò stesso quasi rassicurante, “Ballad of a Thin Man” produce solo smarrimento. Qui il dialogo è impossibile, alle domande fanno seguito altre domande incongrue, il senso è svanito completamente: “And you ask, ‘Is this where it is?’ / And somebody points to you and says ‘It’s his’ / And you say, ‘What’s mine?’ / And somebody else says, ‘Where what is?’”. Capito? No.
Ma il brano che ancora mi mette i brividi è “Queen Jane Approximately”. Da subito, dalle prime parole, quando, dopo la frase di piano che sembra innocua, una scala quasi puerile, Dylan dice: “When your mother sends back your invitations…”. Lo schema (lo avrei capito dopo anni di ascolti e di letture sull’argomento) è quello classico di lui che spiega a una reginetta sdegnosa che è venuto il momento di darsi una regolata (è, fra l’altro, lo stesso di “Like a Rolling Stone”: repetita iuvant, evidentemente). Ma a quattordici anni io non capivo quasi niente di tutta la storia e del fatto che con ogni probabilità Dylan ce l’aveva con Joan Baez (la quale ce l’aveva con lui per le identiche ragioni, e forse a più buon diritto). A quattordici anni, tra i vapori dell’acqua calda, quegli inviti che venivano respinti (inviti di chi, a chi, e per cosa, esattamente?) mi mettevano ansia e mi sembravano l’inizio di una vicenda che partiva male e non poteva che finire peggio, un dramma dell’incomprensione e del rancore su cui proiettavo le mie inquietudini di adolescente perennemente innamorato di fanciulle le cui madri – ne ero certo – erano pronte a intercettare i miei inviti e a gettarli via condannandomi a una vita di solitudine e di infelicità, riscattata solo dalla musica. Praticamente tutto ciò che temevo. E desideravo.