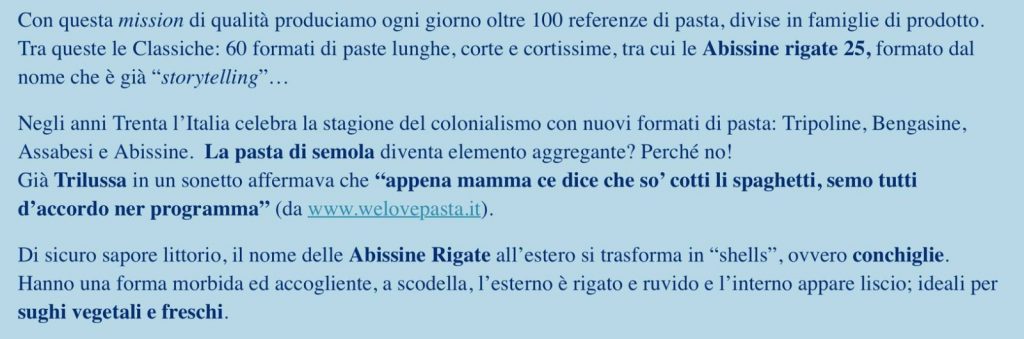Senza lasciarci il tempo di tornare alla scrivania (o di accendere Teams) il 2021 si apre con un caso che non può non attirare la nostra attenzione di comunicatori.
Senza lasciarci il tempo di tornare alla scrivania (o di accendere Teams) il 2021 si apre con un caso che non può non attirare la nostra attenzione di comunicatori.
I fatti. Nei primissimi giorni di gennaio qualcuno nota che alcuni tipi di pasta de La Molisana – un’azienda conosciuta e molto apprezzata per la qualità del suo prodotto – hanno nomi che rimandano al passato coloniale italiano, come le Abissine e le Tripoline. Me ne accorgo quasi subito quando a riprendere e a stigmatizzare il fatto è Niccolò Vecchia, giornalista specializzato in cibo (conduce il programma C’è di Buono su Radio Popolare), nonché caro amico (e contatto su Facebook).
Il post di Niccolò è piuttosto drastico, come è nel suo stile, ma chiaro. A me, devo dire, colpisce immediatamente – più che i nomi delle paste, su cui ritorneremo – il testo della pagina del sito dedicato alle Abissine.
Leggiamo insieme, con calma.
Si parte con l’inevitabile mission: se ne poteva fare a meno, proprio perché siamo su un sito in fondo fatto bene di un’azienda italiana che punta sulla tradizione, ma passi. Alla fine del primo paragrafo arriva l’imputato: le Abissine rigate 25, “formato dal nome che è già ‘storytelling’…”. Qui il mio occhio di comunicatore inizia a rilevare qualcosa che non va. Perché storytelling e non – semplicemente – storia? Perché tra virgolette? E perché quegli inutili, brutti, dilettantistici puntini di sospensione? Che cosa c’è, da sospendere? C’è forse una frase interrotta a metà? Un possibile finale a sorpresa? No.
Nel secondo paragrafo il caos prende il sopravvento. L’autore o autrice dei testi ci spiega che “negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi, Abissine”. Fin qui, io avrei sconsigliato l’uso del verbo “celebrare”, che forse era pur vero all’epoca ma risulta un po’ delicato alla luce della sensibilità di oggi, ma l’assunto di fondo è vero: le paste si chiamano così. Subito dopo, però, le cose precipitano. “La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no!”.
Allarme rosso. Che la pasta di semola sia “un elemento aggregante” è probabilmente vero, e sospetto che tutto il cibo lo sia, magari da qualche millennio. Ma scritto così, in quel punto, sembra che diventi aggregante solo alla luce delle imprese coloniali italiane, il che rappresenta un assurdo logico, prima che storico o politico. E poi “Perché no” è una domanda retorica e quindi va scritto col punto interrogativo, non con il punto esclamativo.
Siamo alla fine. Dopo una citazione di Trilussa poco coerente con il contesto arriva il colpo di grazia. Il terzo paragrafo inizia infatti con “Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate… ”. Eccetera.
Notate – di sfuggita, ma non troppo – che la parola “Rigate” era minuscola nella prima riga, mentre ora è diventata maiuscola senza apparente ragione. Ed è da qui, dai particolari, che si capisce tutto. Chi ha scritto questo testo non ne ha le competenze. Non conosce la grammatica, la sintassi e neppure il significato esatto delle parole che usa. È un automobilista che guida bendato: può andargli bene, finché la strada è dritta e non passa nessuno, oppure può andare a sbattere. Siamo ormai nel regno del caso. E infatti il “sapore littorio” è un incidente imperdonabile. Di che cosa sa, il “sapore littorio”? Di olio di ricino? Di sangue?, hanno commentato molti in rete.
A prima vista, insomma, scrivere “di sicuro sapore littorio”, cioè “fascista”, appare una provocazione consapevole. E infatti è qui che l’azienda si trova senza difese. Per una colpa grave, ma a mio avviso diversa da quella per cui è finita sotto i riflettori.
La polemica scoppia sui social e monta fino a un articolo su Repubblica e su altre testate. Addirittura l’Anpi locale ribadisce la salda collocazione antifascista della famiglia Ferro, titolare del pastificio, o comunque del suo fondatore (il che non è la stessa cosa, beninteso, ma non è questo il punto). La responsabile marketing dell’azienda, Rossella Ferro, si affretta a scusarsi per “non avere controllato le schede prodotto redatte dall’agenzia” e annuncia che non solo i testi contestati – il sapore littorio e il gusto coloniale – scompariranno, ma i prodotti cambieranno nome: in men che non si dica le Abissine rigate 25 sono già diventate Conchiglie rigate 25.
CHE COSA CI INSEGNA QUESTA STORIA? VI DICO LA MIA.
Secondo me i signori Ferro non sono fascisti o comunque se per assurdo lo fossero non sarebbe per questo che quei testi un po’ incoerenti sono apparsi sul loro sito. Qui, come ho cercato di dimostrare poco fa, il linguaggio è utilizzato senza alcuna cognizione di causa: basterebbero, a dimostrarlo, le maiuscole, i puntini di sospensione, il punto esclamativo, la sintassi. Il resto – cioè i disastrosi equivoci – viene da sé. Mentre nessuno si farebbe operare al cuore da un dilettante, da un amico, dal proverbiale cugino, ma anche da una struttura professionale di scarsa qualità (almeno potendo scegliere), con la comunicazione non è così. Con la comunicazione si sottovaluta il problema, si banalizza: “uno vale l’altro”, “la nostra agenzia è vicina, la chiamiamo e viene”, “per la nostra agenzia siamo il cliente principale, ci rifanno le cose anche di notte”. Paradossalmente, in molti casi l’insuccesso dell’agenzia è il motivo della scelta: è debole, è ricattabile, corre, lavora di notte, costa poco. E così invece di cercare il miglior cardiochirurgo, aziende anche ricche e importanti finiscono per scegliere il peggiore.
Se invece, come temo, La Molisana ha agito con coscienza e si è affidata a un’agenzia leader, magari chiedendo “lo sviluppo di un concept creativo in grado di raccontare la storia e i valori distintivi del brand” (come risulterebbe dalla stampa di settore), allora la questione diventa ancora più complessa e riguarda la capacità di chi fa il nostro lavoro di rispondere realmente alle richieste del cliente. Chiedete a un’agenzia di comunicazione “Voi fate anche…?”, e sentirete in risposta un “Sì” convinto, pronunciato ancor prima di avere sentito il complemento oggetto. Il nostro, malgrado la ridicola grandeur di alcuni, è un settore povero: povero di soldi e di autorevolezza. E il riflesso condizionato è quello ci portare a casa più lavoro possibile. Anche quello che non si sa fare (“Poi qualcuno lo troviamo”, dice in genere spavaldamente il capo dell’agenzia, e tutti ridono). È, questo, il gemello del peccato di sottovalutazione che commettono le aziende quando chiamano il “cugino”. Una sottovalutazione uguale e contraria, ma ancora più colpevole perché spetta al consulente – e non al cliente – conoscere i limiti del proprio ambito professionale. Il risultato è che il nostro settore rimane povero e poco autorevole, anzi lo diventa in misura maggiore, proprio a causa di comportamenti maldestri come questo, che ne riducono ulteriormente la credibilità. Se sapessimo dire “No, io questo non lo so fare”, saremmo ugualmente poveri, ma più credibili e quindi – forse – un po’ meno poveri in prospettiva.
Attenzione: non conosco l’agenzia o il professionista che ha scritto i testi e non mi interessa. Leggo i testi e rilevo una leggerezza madornale che non dovrebbe essere consentita nemmeno a uno studente superiore. Quello che mi interessa è evidenziare un meccanismo tipico di sottovalutazione della comunicazione aziendale, almeno fino a quando si presenta sotto forma di una crisi già grave. Allora, magari, si corre dal costoso esperto di crisis management (parte dello stesso gruppo dell’agenzia che ha fatto il guaio?) quando sarebbe bastato fare le cose bene per tempo.
Ho terminato poco fa la lettura del secondo libro della “Trilogia di M” di Antonio Scurati. E so che l’avventura coloniale italiana è stata violenta e ripugnante persino in un contesto bellico, con l’uso dei gas chimici ai danni delle popolazioni civili: pertanto ogni riferimento a quei fatti va maneggiato con estrema cura (e cultura). La storia, naturalmente, non va rimossa, ma va conosciuta, come dice proprio Scurati: pertanto io non avrei cambiato i nomi delle paste (anche se capisco la mossa, nel contesto di crisi), bensì avrei fatto un vero lavoro di racconto per contestualizzarli. Così, quello che è avvenuto è un piccolo ma dolente episodio di cancel culture che nega la storia, che spegne la luce su una stanza in cui abbiamo lasciato un po’ di disordine invece di accendere la luce e riordinarla.
MORALE: LA SAPETE LA STORIA DEL PANDA?
Un panda entra in un bar (la storia si svolge in Inghilterra), ordina un caffè, uccide il barista con un colpo di pistola e se ne va. Uno dei presenti gli chiede spiegazione del gesto e il panda, sorpreso della domanda, gli mostra un manuale di zoologia nel quale si dice chiaramente che il grosso mammifero di origine asiatica “eats, shoots and leaves”, cioè “mangia, spara e se ne va”. Tutta colpa di una virgola: se infatti il redattore avesse scritto correttamente “eats shoots and leaves”, cioè “mangia germogli e foglie” il povero barista sarebbe ancora vivo.
Di virgole, insomma, si può morire, come mi affanno a spiegare quando ne ho l’occasione, specie alle ragazze e ai ragazzi più giovani, che con il loro curriculum vitae stanno facendo la prima e più importante operazione di marketing della loro vita. La Molisana non è morta e io in tutta sincerità non auguro mai il male di un’azienda, specie quando fa bene il suo lavoro: anzi. Però ha perso certamente un po’ di sangue e – per restare nella metafora – le auguro di scegliere meglio i suoi medici, da adesso in poi. Fuor di metafora, la signora Ferro (unitamente alla sua agenzia) ha sulla coscienza non certo i morti in Abissinia, ma un lavoro che dovrebbe essere importante e che invece è stato trattato con superficialità (e, se posso permettermi, le consiglio di dare un’occhiata anche alla sua biografia sul sito, inutilmente agiografica e priva di informazioni di merito).
EPILOGO: IL GAMBERO ROSSO (DI RABBIA)
Questa mattina, al risveglio, invece della calza della Befana ho trovato un articolo del Gambero Rosso che difende La Molisana con toni – fin dal post che lo annuncia su Facebook – che definire eccessivi è riduttivo. Le prime dieci righe, infatti, sono dedicate a spiegare – citando strumentalmente Umberto Eco – che i social “hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli” e proseguendo con parole sobrie come “l’esercito depensante di quelli che Enrico Mentana chiama ‘webeti’, ovvero rassicuranti dr. Jekyll che una volta aperti Facebook e Twitter si trasformano in feroci mr. Hyde dediti al più meschino cyberbullismo”.
 Questo tanto per delimitare il campo fra chi ha ragione (lui) e torto (tutti gli altri, imbecilli e webeti). Una premessa che squalifica automaticamente chi la scrive, perché punta a screditare gli interlocutori prima ancora di entrare nel merito, cosa che non depone mai a favore della buona fede di chi scrive.
Questo tanto per delimitare il campo fra chi ha ragione (lui) e torto (tutti gli altri, imbecilli e webeti). Una premessa che squalifica automaticamente chi la scrive, perché punta a screditare gli interlocutori prima ancora di entrare nel merito, cosa che non depone mai a favore della buona fede di chi scrive.
L’articolo risponde solo a una parte delle critiche mosse al pastificio, quella sui nomi delle paste, che sono parte della storia e della tradizione, ed è esattamente quanto penso anch’io. Mentre sul “sapore littorio” e sul “gusto coloniale”, i tentativi di giustificazione sono quasi comici: “Il testo in realtà sottolineava come il sapore un po’ troppo littorio del nome del formato avesse suggerito di chiamarlo diversamente all’estero (dunque non un apologia, l’esatto contrario!)”. Ma dove? Ma quando? Se il sapore fosse sembrato troppo littorio all’estensore del testo, avrebbe potuto scriverlo: troppo. E poi che c’entra il fatto che all’estero le chiamino shells? In primo luogo non prova niente, ma soprattutto dovremmo essere noi italiani a sentire il bisogno di fare i conti con un nome così ingombrante: per mantenerlo, magari – lo ripeto per l’ennesima volta – ma contestualizzandolo in modo appropriato.
Insomma, l’articolo firmato da Massimiliano Tonelli mostra un astio davvero incomprensibile nei confronti dei malcapitati che hanno osato pensare male del “sapore littorio” (“una piccola gaffe”, minimizza il nostro). E via di nuovo: “Tutti, nascosti dietro al profilo social, annusano l’odore del sangue e percepiscono forte il dovere di esternare il proprio antifascismo usando, tuttavia, proprio i metodi fascisti dell’imboscata, della pubblica gogna, del pestaggio, della vigliaccheria dei mille contro uno, dell’aggressività gratuita e ignorante”, è uno dei passaggi più garbati di questo presunto manifesto della non-violenza verbale.
Perché tanta partigianeria? Perché tanto furore? Non sarebbe stato meglio – specie da una tribuna così prestigiosa per il cibo italiano – provare a spiegare, capire le ragioni degli uni e degli altri, ricucire, consigliare? No, l’invettiva è a senso unico e chiama in causa persino Laura Boldrini, un’ex presidente della Camera. Lo scrivo, questo epilogo, perché temo che anche il Gambero Rosso con l’occasione abbia commesso un errore di comunicazione (di reputazione, nella fattispecie) piuttosto grave. Potrà, chi ha letto le parole sopra citate, considerarlo ancora una fonte equilibrata e imparziale? Io credo di no.